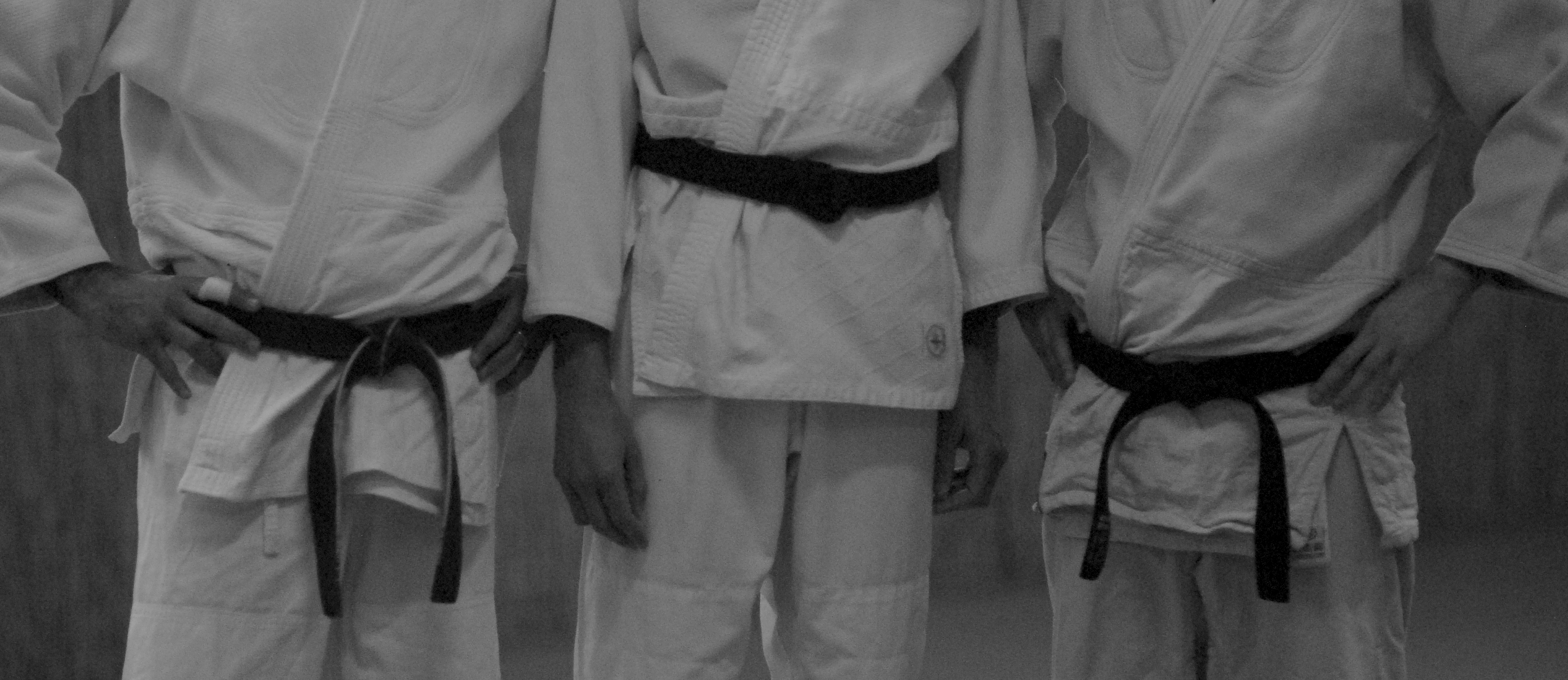Cos’è un Aiki Manifesto?
Un Manifesto anzitutto è una dichiarazione di intenti, oltre che l’esposizione pubblica di un punto di vista su uno specifico argomento, questo è il nostro Aiki Manifesto.
Siamo partiti dai nostri diversi modi di intendere e vivere la pratica dell’Aikido ed abbiamo cercato di raggiungere una sintesi, mettendo a fattor comune tutto ciò che rendeva i nostri personalissimi percorsi un unico cammino da percorrere insieme.
Siamo felici di condividere con voi il risultato di questo lungo lavoro.
Buona lettura e buona condivisione.
La pratica
Può sembrare banale ma occorre partire da ciò che si fa, cioè Ki Aikido.
Il Ki Aikido secondo l’insegnamento del Maestro Yoshigasaki è l’arte che abbiamo scelto di studiare e di diffondere.
Parliamo di Ki Aikido intendendolo come un unico macro-contenitore delle molte cose strane che facciamo. Riteniamo infatti che il Ki Aikido di Yoshigasaki non sia quello di Tohei, ma non sia ovviamente nemmeno l’Aikido di Ueshiba o di Saito o di Tada.
Non ci interessa distinguere la pratica del Ki da quella dell’Aikido anche se lo studio dei test di Ki rimane ovviamente l’elemento distintivo della nostra pratica, fondante e fondamentale.
Ki è rappresentato dall’ideogramma giapponese che nei caratteri della scrittura Kanji raffigura il “vapore che sale da riso in cottura“. Qualcosa di etereo quindi, ma ben presente. E’ una disciplina fisica che insegna a percepire sé stessi in modo unitario, ma separato dal mondo dei pensieri, dei sentimenti e delle emozioni.
Uno studio che si completa in maniera vicendevole con la respirazione, la meditazione, il Kenko Do e, ovviamente, l’Aikido.
Molti sono i momenti storici che hanno visto lo sviluppo e l’evoluzione dell’Aikido dal primo novecento ad oggi e suo il bagaglio tecnico, estremamente ampio e flessibile, consente di scegliere una condotta d’intervento assai varia, che in ogni caso mantiene ferma la convinzione che per cambiare il mondo occorre cambiare sé stessi.
Si potrebbe dire che l’Aikido è come una lavagna e le tecniche sono il gesso. Ciò che siamo si traduce in ciò che facciamo.
Proprio per questo crediamo nell’importanza dell’evoluzione dei concetti e nel loro sviluppo, tratti sicuramente distintivi e peculiari dell’Aikido del nostro Doshu. E questo nostro potenziale si esprime al meglio quando è sostenuto da una piattaforma di elementi comuni, fondata su ciò che noi riteniamo imprescindibile, oltre che fortemente connaturato con la nostra pratica:
- Il lavoro su di sé. La vera vittoria è quella su noi stessi e d’altronde il confronto con ciò che ci circonda è quotidiano. Ci siamo noi e poi ci sono gli altri: le relazioni, il lavoro, l’azione e gli ostacoli. Non esiste una regola per ogni situazione, non ci sono ricette a priori. Dalle esperienze possiamo trovare arricchimento, competenze che ci aiutino nel nostro percorso. L’inizio ci riguarda, dobbiamo conoscerci e, per quanto difficile possa essere, migliorarci. Praticare Aikido con la mente libera può permettere all’increspatura dell’acqua di distendersi e riflettere le immagini più chiaramente, anche quelle del nostro animo
- La relazione. Il Ki Aikido permette di unificare la percezione di mente e corpo attraverso i test, la respirazione, il misogi. Con le tecniche di Aikido ci confrontiamo in maniera attiva con ukemi e con lo spazio che ci circonda e possiamo ottenere una visione d’insieme più complessa e condivisibile.
- Il miglioramento continuo. La disciplina non si esaurisce con il raggiungimento di un grado, ma sviluppa coscienza critica verso un miglioramento continuo. Non si finisce mai approfondire la ricerca e conquistare energie positive.
In estrema sintesi, o l’Aikido è una pratica di vita oppure non è.
I praticanti
Senza praticanti non c’è pratica perché l’Aikido non si può fare da soli e questo è il suo limite, ma anche il suo più grande valore. Oggi il numero dei praticanti si sta riducendo, manca il ricambio e più in generale l’età media sul tatami diventa sempre più alta. E’ un cane che si morde la coda, mettiamoci nei panni di un principiante che sale sul tatami per la prima volta, egli troverà persone più avanti di lui nella pratica anche di decenni, che fanno delle cose strane che sembrano capire solo loro, spiegandole mediante un un linguaggio e dei concetti che ad un neofita potrebbero essere totalmente estranei.
Il rischio tangibile di uno scenario del genere è sia quello di respingere i nuovi allievi che di avventurarsi sul sentiero senza ritorno dell’autoreferenzialità.
La sfida che ci proponiamo a livello personale e collettivo, come studenti ed insegnanti, è quella di riuscire ad accogliere e attirare persone nuove, anche anagraficamente più giovani, senza però introdurre elementi estranei, come ad esempio le competizioni o il combattimento sportivo, che a nostro modo di vedere nulla hanno a che spartire con quanto si fa all’interno della pratica che ci siamo scelti.
Maestri e allievi
Il rapporto con il proprio maestro è forse uno dei grandi tesori della pratica delle arti marziali.
Un maestro non è un semplice allenatore: ti guarda, ti conosce ed ha a cuore la tua crescita ed il tuo miglioramento. Sicuramente è uno degli elementi più personali della pratica e forse è uno dei più difficili da approcciare quando si passa da allievo ad istruttore.
E’ bene chiarirlo, non tutti sono tagliati per insegnare. La competenza tecnica e la voglia di approfondire e migliorarsi sono necessarie, quasi obbligatorie, ma potrebbero non essere sufficienti.
Un buon maestro deve sempre riflettere accuratamente sulle ragioni di ciò che sta insegnando, deve averle dentro. Deve risultare credibile nella sua figura e nelle sue proposte dentro e fuori dal tatami e questo possono essere solo gli allievi a valutarlo.
Un buon maestro non deve avere l’ansia del grado. Un insegnante abitualmente possiede un diploma dan, ma non è il grado a fare il maestro.
Dobbiamo ricordare sempre che lo scopo dei passaggi di livello non dovrebbe essere (esclusivamente) quello di gratificare l’ego del praticante, ma di creare una struttura, all’interno di un dojo così come della scuola.
Pertanto, ogni istruttore deve sempre interrogarsi sull’adeguatezza del grado che possiede rispetto al ruolo e all’Aikido che esprime.
D’altro canto anche gli allievi devono tenere un atteggiamento corretto nei confronti di chi insegna. Non solo nel proprio dojo, ma anche durante i seminari e le lezioni in altri luoghi. E’ necessario che gli studenti come gli insegnanti mantengano davvero costantemente una mente da principianti, siano cioè disponibili a provare cose nuove, a dissolvere le proprie certezze rovesciando il proprio punto di vista. Solo in questo modo si può mettere alla prova le proprie convinzioni e rafforzarle o evolverle.
Il dojo
Si può praticare anche in un parco pubblico, ma guardando la cosa da un punto di vista oggettivo per fare Aikido servono un dojo e i tatami. Purtroppo in un momento storico in cui tutto deve avere un profitto ed una sostenibilità economica più che certi non è facile trovare spazi adatti alla pratica.
Quasi sempre ci si trova a fare lezione in sale prese in affitto in scuole o palestre che nulla hanno a che vedere con la dimensione marziale della nostra arte.
Il lavoro deve diventare quindi quello di percepire il locale nel quale facciamo Aikido come sospeso dentro una bolla, uno spazio fisico separato anche mentalmente dall’esterno nel quale poter praticare con la massima attenzione e dedizione.
Il dojo infatti educa al rispetto: rispetto per il luogo e per ciò che si fa al suo interno. In definitiva, rispetto per sé stessi.
Dovunque sia, il dojo è un posto dedicato ad un percorso tutto nostro e come tale dovremmo trattarlo, tenendolo pulito, in ordine e sempre adatto alla pratica.
La scuola
Pratichiamo un’arte di Relazione ed allora è essenziale la relazione tra le realtà di pratica, i dojo ed i maestri. Siamo pochi, pochissimi e molto francamente se continuiamo a dividerci rimarremo anche meno. Purtroppo l’alternativa ad essere suddivisi in modo pulviscolare troppo spesso sembra essere quella di venire assorbiti da entità più grandi.
Noi non crediamo in nessuno dei due modelli.
Crediamo in una rete strettamente cooperante di piccole realtà che abbiano tra di loro continui scambi ed interazioni, in cui gli istruttori si incontrino periodicamente per condividere ed evolvere le proprie capacità e progredire insieme.
Ki No Nagare