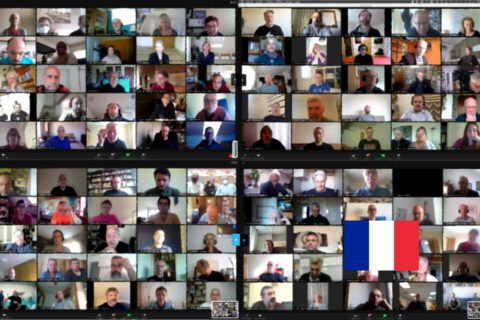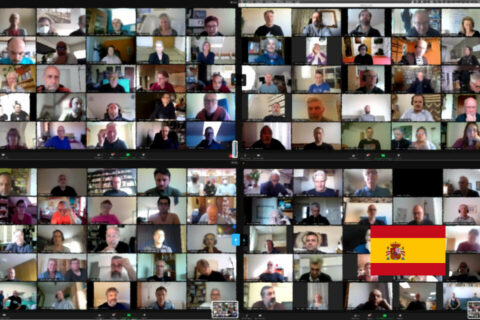Da Oriente a Occidente
L’Occidente ha sempre guardato verso l’Oriente sopraffatto dal tipo di fascino che si prova verso le cose che non si riescono a capire bene, ma a sfiorare soltanto. Da sempre i viaggiatori e gli artisti europei hanno allungato la mano verso le terre “dove si leva il sole” e hanno cercato di toccarle, ma queste sono sempre rimaste lontane, incredibilmente lontane.
Nel Medioevo, Marco Polo riporta in patria veri e propri stralci d’India, descrivendone le cerimonie religiose, piene di colori e profumi che nella sua Venezia forse si riescono soltanto a immaginare, di danze nelle strade a cui partecipano non ballerini umani, bensì gli stessi dei in persona che gareggiano contro demoni dal viso pitturato e cupo. Diversi secoli dopo, lo scrittore romano Diego Della Valle torna dal suo viaggio in Oriente con la bocca piena di racconti su come le celebrazioni e le feste vengono curate: nei balli che riempiono i templi, non si danno mai le spalle agli idoli e le danze vengono eseguite sul ritmo leggero dato da piatte bacchette di legno.

Un momento del Kotodama…
Le testimonianze vengono accolte con grande entusiasmo. Affascinano i colori vividi, le leggende lontane, gli odori caldi. Ma più di ogni altra cosa, ce ne è sempre una che colpisce l’immaginazione a Occidente: il movimento. Sempre pulito, sempre pieno di mistero, sempre sensuale.
Due secoli ancora e le Indie diventano terre di conquista.
Le opere sceniche occidentali cominciano a inserire al loro interno dettagli che ricordino quei paesaggi mitici e le loro danze, quei movimenti e gesti strappati con fatica e immaginazione a memorie lontane.
Alla fine dell’Ottocento, quando già il fascino per la Cina e il Giappone ha innervato la produzione pittorica e artigianale, alcune compagnie di teatro orientale girano l’Europa, incrementando curiosità e desiderio.
L’interesse amoroso dell’arte occidentale per quella orientale ha radici antiche. Ma è qui e ora che scocca davvero il colpo di fulmine: nel momento in cui l’artista d’Occidente riesce ad allungare lo sguardo e a vedere il guerriero d’Oriente.
Quando un guerriero incontra la confusione
Quando Antonin Artuad, uno tra i principali esponenti del teatro europeo del Novecento, si imbatte nel teatro orientale all’Esposizione Coloniale di Parigi del 1931, si trasforma.
Un’idea, una scintilla di consapevolezza nuova cambierà la sua arte, la sua stessa vita e tutto il modo di fare teatro in Occidente.
Quello che Artuad trova nell’arte scenica orientale quella notte e nelle ricerche a venire, non è diverso da ciò in cui si imbatte un qualsiasi praticante di arti marziali quando comincia a studiare nel dojo: una serie di esercizi precisi, uno schema di comportamento da seguire, un disegno di movimenti che compone la tecnica, una partitura d’azioni.

…e “La danza delle donne”, una coreografia ad esso ispirata
Ma non solo. L’uomo che diventerà uno dei più grandi maestri della regia del Novecento si imbatte in qualcosa di nuovo, che gli toglie il fiato.
Antonin Artuad, in quel periodo, è un uomo distrutto. Massacrato dagli interventi chirurgici, dagli anni in manicomio e logorato dai brutali elettroshok subiti in qualità di terapia, ha un corpo devastato che non risponde più. È incollerito, muove attacchi durissimi alla letteratura e al bello stile. A tutta l’arte, scenica e non, che percepisce inamidata e immobilizzata.
Il teatro per come lo conosce è vecchio e stantio, moribondo quanto il suo corpo. È necessario appellarsi a quel qualcosa di ineffabile, ma percepibile, a un linguaggio nuovo che passi attraverso una fisicità nuova.
Nella ricostruzione dell’arte scenica, trova un modo per ricostruire se stesso, dopo avere fatto a pezzi il proprio corpo e quello di un’arte sclerotizzata, incollata allo stile letterario, al testo che soffoca il movimento.
È tormentato dalla crisi che coglie sempre il ricercatore quando mette piede in terre inesplorate, ma quello in cui si imbatte Artaud senza saperlo, e davanti a cui si meraviglieranno i teatranti del Novecento, è il ki.
Ki e Bios
Artuad coglie nei movimenti del teatro orientale qualcosa di impercettibile, o quasi, che viene lavorato e guidato attraverso l’esercizio, attraverso lo schema di comportamento e il disegno dei movimenti.
Un praticante di aikido chiamerebbe quel qualcosa ki, riconoscendone istintivamente le caratteristiche.
“Esistono molti significati differenti attribuiti all’ideogramma ki” scrive il Maestro Giuseppe Ruglioni. “Potrebbe essere tradotto come mente, interesse, natura, disposizione, energia, vapore, profumo e un’infinità di altri significati. Usato spessissimo nella lingua corrente giapponese, è di per sé intraducibile in un unico termine”.
Ma non importa. Quello che importa è che sia percepibile.
In aikido siamo portati a considerarlo qualcosa di simile all’energia vitale che è alla base del movimento e della vita. Presente in ogni cosa, il ki non è un’energia individuale, ma universale e, proprio per questo, fluisce e permane nei corpi. Se non si può accumularlo come un tesoro privato, lo si può però riconoscere e allenare.
In Oriente si tratta di una consapevolezza antica, ma l’Occidente si sbalordisce davanti alla “mente che guida il corpo”, perché della mente e del corpo, per secoli, ha visto la contrapposizione dicotomica.
Antonin Artuad e i suoi contemporanei ci si aggrappano con le unghie. Vogliono una recitazione senza parole, fatta di gesti e movimenti codificati che esprimano tutto, senza dire niente. Che siano efficaci.
Il ki viene definito bios scenico per la prima volta da Eugenio Barba, maestro della scena teatrale della seconda metà del Novecento. È l’energia vitale che tiene in connessione il corpo e la mente.
Barba deve smontare lo stesso concetto di mente, tra gli allievi del suo teatro. Non si fa riferimento alla componente razionale, al processo analitico che, durante l’azione, non fa che rallentarla e la rende innaturale o impacciata. Si tratta invece di quello stato di attenzione e lucidità che acuisce i sensi e permette la visione periferica; la totale rilassatezza del corpo attivo, l’attesa carica di tensione che precede l’azione.
“Corpo e mente” sostiene “diventano come fodera e foggia di uno stesso abito: non esiste un dualismo fodera-vestito.” E poi: “questa energia può essere manovrata, modellata, sfaccettata, assorbita e fatta danzare dentro al corpo. Non sono fantasticherie! Sono immaginazioni efficaci!”
Per spiegarlo al meglio, Eugenio Barba porta le arti marziali nei suoi laboratori teatrali.
Il cigno sull’acqua
Fudoshin è un concetto che sta alla base dell’aikido e che ricorre spesso nelle arti marziali in generale. È un termine che è stato tradotto per molti anni come “mente inamovibile” per sottolineare il fatto che la mente del praticante non viene distolta dalle emozioni, ma rimane salda. Poi, però, si è ritenuto meglio tradurre con “mente imperturbabile” per non creare l’equivoco di una mente immobile, congelata.
 È proprio il contrario, infatti.
È proprio il contrario, infatti.
La “mente inamovibile o imperturbabile” indicata da fudoshin rappresenta lo stato di integrazione mente-corpo in cui la mente è così libera da permettere al corpo di utilizzare tutte le sue potenzialità.
Il maestro Koichi Tohei la definiva così: “il vero fudoshin non è un rigido, immobile stato della mente, ma è la condizione di stabilità che viene dal rapido movimento, in altre parole lo stato di perfetta stabilità fisica e spirituale proveniente dal movimento che continua infinitamente ed è così infinitamente rapido che è impercettibile.”
Fudoshin si realizza quando siamo nelle condizioni di elevare al massimo il nostro grado di percezione fisica e mentale, quando possiamo godere della migliore relazione possibile tra noi e lo spazio che ci circonda.
La mente è libera, non fissata su qualcosa, ma concentrata sul corpo e in piena possibilità di pervaderlo. La mente non si muove semplicemente perché riempie tutto lo spazio, lo satura rimanendo leggera.
Nell’insegnamento del Maestro Koichi Tohei si trova spesso l’idea del fudoshin che crea il fudotai, ovvero la “mente inamovibile” che determina il “corpo inamovibile”. Essendo il corpo-mente un unicum, se la mente è calma e cosciente di sé, abbastanza da essere imperturbabile ai fattori esterni, è evidente che anche il corpo possa raggiungere lo stesso stato.
Ingemar Lindh, teatrante del Novecento, arriva alle stesse conclusioni con parole diverse. Auspica a ottenere una “intenzione nell’immobilità: il gatto che non fa nulla, ma che vuole ghermire una mosca.”
L’ineffabile bios scenico di Eugenio Barba definisce il corpo dell’attore in movimento quanto in stato di quiete. Se quest’energia che fa di mente e corpo un’unica realtà guida il movimento in una direzione o sostiene l’urgenza di un’azione, cosa le succede quando tutto cessa e il corpo deve restare fermo nello spazio scenico? L’energia permane.
La fisicità dell’attore ne è ancora piena, il corpo è ancora vivo, rilassato e attivo.
Se essa venisse a mancare, il corpo sarebbe come svuotato internamene, tornerebbe neutro e inespressivo, senza tensioni e attenzione. Si perderebbe la continuità tra un’azione e l’altra e si assiserebbe a dislivelli enormi di energia nel momento in cui l’azione dovesse riprendere.
Allo stesso modo, un praticante di aikido che esegue una sequenza di tecniche, non lascerebbe mai “cadere” il ki tra l’una e la successiva: interromperebbe il lavoro.
“Quando non si muove quel che è visibile, il corpo” dice Eugenio Barba, senza sapere di spiegare il fudoshin “bisogna avere l’invisibile, la mente, in movimento. È il modello del cigno sull’acqua: scivola impassibile, ma le sue zampe nascoste lavorano senza sosta. Nel moto, l’immoto; nella quiete, l’inquieto.”
(Continua)
Scilla Bonfiglioli
La danza nelle foto è stata realizzata dalla “Compagnia Teatrale I Servi dell’Arte” https://www.facebook.com/I-Servi-dellArte-128008953933556/?fref=ts