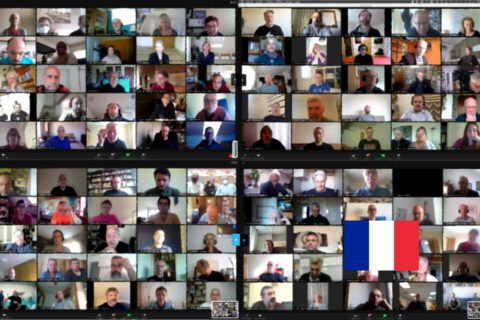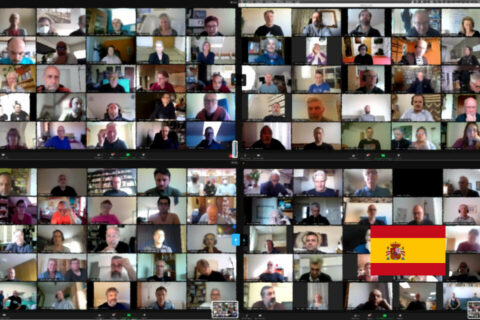Avere “koshi”, avere il Punto
“L’uomo è malato perché è mal costruito”, sostiene con veemenza il grande commediografo del ‘900 Antonin Artuad. Ed è anche uno tra i primi a occuparsi di questa sorta di schizofrenia tra il mente e il corpo, sulla scena. Si concentra sui frammenti di un corpo destrutturato, per poi ricostruirlo.
 Se gli arti sono “segmenti”, linee infinite e indipendenti, il tronco – ovvero la porzione che va dalla base del collo al bacino – ne viene considerato il cardine. A esso viene conferito il primato assoluto in qualità di centro propulsore del movimento, il punto espressivo del corpo, in grado di comunicare emozioni, sensazioni e informazioni.
Se gli arti sono “segmenti”, linee infinite e indipendenti, il tronco – ovvero la porzione che va dalla base del collo al bacino – ne viene considerato il cardine. A esso viene conferito il primato assoluto in qualità di centro propulsore del movimento, il punto espressivo del corpo, in grado di comunicare emozioni, sensazioni e informazioni.
Come nelle scuole tradizionali giapponesi, questo “fuoco centrale” coincide esattamente con il baricentro del corpo umano, la base dell’equilibrio e del corpo rilassato e in potenza. Viene situato nell’hara, ovvero la porzione di bacino racchiusa tra le anche, traducibile con “centro” e richiama il luogo in cui si sviluppa la vita, origine dell’energia di tutto il corpo.
I Maestri di teatro giapponese fanno riferimento a questo punto stabile con l’espressione “avere koshi“, ossia “avere le anche”.
“Noi diciamo che un attore ha o non ha koshi per indicare che ha o non ha la giusta energia nel lavoro” afferma l’attore Kabuki Sawamura Sojuro, sottolineando l’importanza di una postura corretta sulla scena che, in Giappone, coincide con quella richiesta dai praticanti di arti marziali in un qualsiasi dojo.
Poco più di una decina di anni fa soltanto, nella scuola dello Shin Shin Toitsu Aikido, si parlava di “mantenere il Punto”.
Era un’espressione che aveva acquisito poi, nella mente dei praticanti, talmente tanto realismo e fisicità da deformare la postura. A causa di ciò, l’espressione venne eliminata in favore di altre che prediligono immagini didattiche più efficienti per la scuola.
Tuttavia la citazione è d’obbligo, nel contesto. 
Con “il Punto” si definiva una zona del corpo posizionata nel basso ventre, dove era necessario portare l’attenzione, ovvero “collocare la propria mente”.
“Se provate a contrarre il vostro addome” scrive il Maestro Giuseppe Ruglioni “troverete, piuttosto in basso, un piccolissimo spazio che non è possibile contrarre. Questo è il Punto.”
In questo modo veniva definita, con un’immagine puramente mentale, quella stessa hara di cui si parlava nel descrivere koshi. Per “mantenere il Punto” era necessario portarvi l’attenzione che garantiva al corpo intero la massima stabilità durante la pratica e un perfetto stato di unificazione mente-corpo.
Partiture e kata
Nella vita quotidiana, raramente il corpo che si muove è cosciente. Accadono troppe cose, ci si deve occupare di situazioni sempre diverse e spesso si compiono delle azioni pensando ad altre. Essere coscienti di tutto è quasi impossibile.
Crescendo, a partire dalla nascita, un individuo è costretto ad assimilare esperienze e a creare, nel proprio corpo e nella propria mente, automatismi che vengono eseguiti senza pensare, che gli permettano di far fronte a situazioni senza doverle vagliare di volta in volta.
Se sono azioni che adempiono al loro scopo nel quotidiano – afferrare un libro sullo scaffale è possibile anche mentre si pensa a che treno prendere il mattino successivo – sono però inefficaci dal punto di vista del corpo-mente. Per chi pratica aikido, così come per i teatranti.
In questo ambito di particolare interesse è il concetto di kata.
 Nel teatro giapponese, che sia il Nō o il Kabuki, le partiture e gli schemi di movimento vengono chiamati kata.
Nel teatro giapponese, che sia il Nō o il Kabuki, le partiture e gli schemi di movimento vengono chiamati kata.
“Lo si potrebbe definire un messaggio del passato, trasmesso dall’una all’altra generazione attraverso piccole o grandi partiture di movimenti e di azioni vocali” spiegava Eugenio Barba. “Di per sé il termine kata non ha nulla di esoterico o misterioso. Il suo campo semantico, nel parlare comune, corrisponde più o meno a quello di termini come “forma”, “stampo”, “pattern” o “modello” nelle lingue europee. Per l’attore può riferirsi al disegno di un singolo movimento, di una singola posizione, oppure a una sequenza di azioni strutturata, una vera e propria partitura di un intero ruolo. Un kata può trasmettere la versione dettagliata e precisa (perciò extraquotidiana) di un’azione realistica”.
Il termine kata ricorre anche nelle arti marziali giapponesi, con lo stesso significato. Nel karate, per citarne una su tutte, si usa per definire le sequenze di tecniche individuali. Per l’aikido il discorso è diverso, dal momento che le sequenze prevedono la pratica di coppia, meno codificabile, preferendo altre terminologie, anche se kata permane tuttora per definire le sequenze di tecniche con le armi.
L’allenamento di un praticante di arti marziali, in Oriente, non è diverso da quello di un attore di teatro tradizionale.
Il corpo “quotidiano”, con i suoi automatismi, viene smontato e rimontato per crearne altri, più eleganti, efficaci ed economici, attraverso l’esercizio prolungato nel tempo.
Zanshin e otkaz
Per essere efficace poi sulla scena, un movimento deve garantire tensione.
Un attore che vuole avvicinarsi al tavolo per prendere un bicchiere d’acqua, non può semplicemente andare. Il movimento che ha un’unica direzione non è sufficiente a catturare l’occhio di chi lo guarda. Risulta vuoto.
Privo di bios. Privo di ki.
Un attore che vuole avvicinarsi allo scaffale per afferrare il libro, deve creare un contrappunto, ovvero un movimento che contrasta con il principale. Se vuole  andare avanti, l’attore deve essere attratto indietro, così come chi vuole saltare verso l’alto deve prima piegarsi sulle gambe. Eugenio Barba chiama questo punteggiare le azioni di contrasti otkaz, che in russo significa, letteralmente, “rifiuto”. Si può visualizzare come il caricamento di una molla prima che essa scatti. Ha la funzione di negare l’azione che invece introduce, sottolineando l’importanza della simultaneità delle azioni stesse.
andare avanti, l’attore deve essere attratto indietro, così come chi vuole saltare verso l’alto deve prima piegarsi sulle gambe. Eugenio Barba chiama questo punteggiare le azioni di contrasti otkaz, che in russo significa, letteralmente, “rifiuto”. Si può visualizzare come il caricamento di una molla prima che essa scatti. Ha la funzione di negare l’azione che invece introduce, sottolineando l’importanza della simultaneità delle azioni stesse.
Questo genere di tensione crea energia e attira l’attenzione dello spettatore, che percepisce il movimento come “extraquotidiano” e trattiene il respiro senza accorgersene, preso all’amo dal gesto. È lo stupore della mente di chi guarda, che non è in grado di far fronte che a una direzione alla volta.
In aikido ci troviamo spesso a dovere lavorare con più di una direzione alla volta. Non “contrastare” significa non scontrarsi con il ki dell’altro, durante la pratica. Imprimere una direzione, implica che il contrasto avvenga per riflesso naturale: una forza impressa in un movimento di nage, infatti, è facilmente riconoscibile e ostacolabile da ukemi. Applicarne due o più, come avviene durante l’esecuzione della tecnica, impedisce alla mente di ukemi di riconscerle e contrastarle. È come fare trattenere il respiro nello stupore.
Naturalmente otkaz non è un termine che viene utilizzato in aikido.
Si avvicina, però, il concetto di zanshin.
“Zanshin significa più o meno parte di cuore o intervallo del cuore” ha spiegato il Maestro Davide Rizzi. “Si riferisce a quel momento di silenzio, brevissimo, che intercorre tra due battiti del cuore. Un momento di calma sospesa, prima che tutto ricominci”.
E’ quel momento che il praticante di aikido, così come il teatrante, deve imparare a percepire e a realizzare, affinché il suo gesto risulti potente, efficace, credibile.
Scilla Bonfiglioli
Le foto pubblicate nell’articolo mostrano una coreografia realizzata dalla “Compagnia Teatrale I Servi dell’Arte” (https://www.facebook.com/I-Servi-dellArte-128008953933556/?fref=ts) e alcuni movimenti con il bokken da cui essa ha tratto ispirazione.