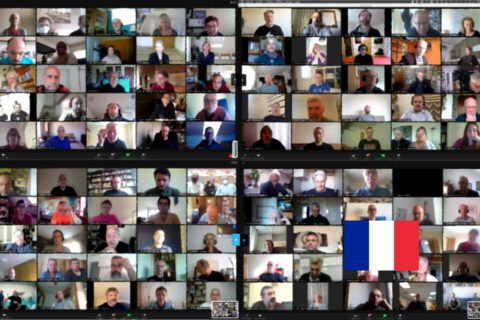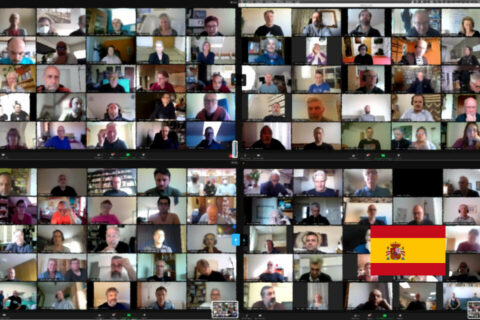Il dojo Shiro Saigo di Prato è molto accogliente, grande e luminoso. Appena entrati si respira subito l’aria dei centri dedicati alle arti marziali, prima fra tutte in questo caso il judo – come testimoniano i trofei e le numerose foto alle pareti – disciplina per la quale la Shiro Saigo è un’importante scuola toscana.
L’ospitalità di Piero e dei suoi ragazzi – e non ne avrei dubitato neppure per un istante – è stata squisita, così come quella del presidente dell’associazione pratese che la domenica mattina è venuto a portare il suo saluto e un omaggio al Doshu.
Apro una parentesi: la nostra non è una disciplina sportiva, ma rimango sempre piacevolmente colpito dallo stile che caratterizza la cultura di un certo associazionismo sportivo.
Nostro compagno per tutta la giornata di sabato è stato il vento di tramontana che dai monti batteva con forza la città e passando tra gli infissi generava un suono simile a quello di un trapano o di un tagliaerba. Ma non sarà tanto per il rumore che ricorderò il seminario di Prato, bensì per due ragioni ben più interessanti.

Rokudan
La prima è che il Doshu sabato ha consegnato il diploma di VI dan a Marco Zaccagnini del Ki Dojo di Firenze e al mio maestro, Davide Rizzi del Centro Ki Aikido Bologna.
Marco aveva ricevuto la notizia venerdì sera, mentre per Davide è stato un passaggio del tutto inaspettato. Quando il Maestro li ha chiamati al termine della consegna degli altri diplomi, la loro emozione era palpabile e confesso che vedendoli lì davanti mi sono emozionato anch’io.
La seconda ragione è che Sensei per la prima volta (almeno alle mie orecchie) ha formulato in modo strutturato i nuovi cinque princip…ehm….CONSIGLI per praticare aikido e ha dato una definizione concettuale di tutte le tecniche.
In particolare ricorderò questi due giorni di lezione perché…beh, diciamo che Sensei nel suo “processo didattico” mi ha preso piuttosto di mira. Ho già espresso il mio apprezzamento sul valore “socratico” delle sue domande a bruciapelo agli allievi (“che cos’è questo?” “che cos’è quest’altro?” ecc.) Ecco: personalmente in questo seminario di domande ne ho fatta una buona scorta.
Mi arrischio quindi ad elencare, così come li ho compresi, i cinque buoni consigli e le definizioni delle tecniche. Come sappiamo la memoria è immaginazione e quindi chiedo perdono in anticipo per gli eventuali sfondoni, anzi invito tutti a commentare il post e a correggermi, se lo ritenete necessario.

S’apre il dibattito…
Cinque consigli per praticare aikido:
- Unificare mente e corpo (fisicamente si sostanzia nel movimento su e giù in punta di piedi con gli occhi chiusi)
- Comprendere l’intenzione del partner (osservando la forma che assume fisicamente – il suo linguaggio del corpo potremmo dire)
- Cambiare forma senza spostarsi
- Spostarsi senza cambiare forma
- Continuare a vivere la propria vita
L’ultimo è il contraltare del quinto principio formulato dal Maestro Tohei per la pratica dell’aikido che recitava “lavorare con fiducia”. E’ interessante perché esprime il passaggio dalla dimensione di sola “produzione” di movimenti sul tatami ad un ambito di applicazione più vasto.
Il verbo “continuare” è stato poi sottolineato dal Doshu con forza, perché la vita è un flusso incessante: c’era prima della tecnica e ci sarà dopo. E il momento stesso dell’esecuzione ovviamente ne fa parte.
Queste invece le definizioni delle singole tecniche:
- Kokyu Nage: usare la propria mano per guidare la mente di uke

Ikkyo
- Ikkyo: controllare il gomito di uke per controllare la spalla
- Nikyo: controllare il polso di uke per controllare il gomito
- Sankyo: usare la mano di uke per controllare la scapola
- Yonkyo: usare il braccio di uke per controllare la scapola
- Zempo Nage: fare in modo che la mente di uke vada su una delle sue braccia e la segua fino a terra
- Kaiten Nage: fare in modo che uke assuma la forma di una palla
- Koteoroshi: piegare il gomito di uke
- Shihonage: piegare il gomito di uke girando su sé stessi
Qui l’elemento che trovo più interessante è che nella maggioranza dei casi non c’è relazione tra il nome della tecnica e il concetto che ne sta alla base. Koteoroshi ad esempio di traduce con “abbassamento del polso”, ma al contrario di ciò che dicevano gli antichi romani, in questo caso nomina NON sunt consequentia rerum.
I nomi non sempre contengono il significato profondo delle cose a cui appartengono.
Grazie per le foto a Stella Marie Scanlon!