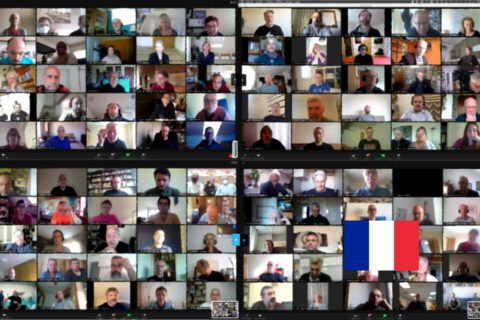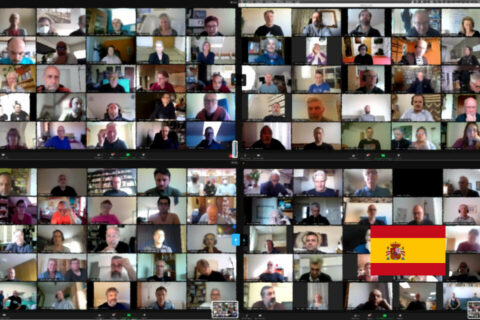I pensieri che mi raggiungono mentre sto correndo sono come nuvole nel cielo. (Haruki Murakami)
Da tempo rifletto su alcuni temi legati alla pratica che mi stanno particolarmente a cuore: il ruolo del ki, la dimensione etica del nostro studio e quale l’identità della nostra scuola oggi e nel futuro.
Le parole dette da sensei Yoshigasaki all’ultimo seminario di Colazza credo però abbiano fatto da “detonatore” e mi hanno spinto a ripercorrere il flusso dei miei pensieri in un autentico kinonagare personale.
IL RUOLO DELLA PRATICA DEL KI
Shin shin toitsu do è la via dell’unificazione mente-corpo. Rispetto alla “mente”, il Maestro Yoshigasaki ha distinto due accezioni del concetto. Da una parte infatti esiste la mente “originaria”, cioè quella non condizionata da pensieri, sentimenti ed emozioni; dall’altra parte esiste la mente intesa come complesso delle facoltà intellettuali ed emozionali dell’individuo, questa invece ovviamente plasmata da pensieri, sentimenti ed emozioni.
Un esempio dell’unione dei due lo ritroviamo quotidianamente nei numerosi gesti automatici che compiamo: dal cambio di marcia dell’automobile alla mano che scatta per prendere al volo il bicchiere che sta cadendo dal tavolo. Questi gesti non sono controllati dal pensiero o dettati dall’emozione. Ed è questo a renderli efficaci.
La pratica del ki fornisce al praticante gli strumenti per percepire questa unione e ritrovarla quando necessario.
LA DIMENSIONE ETICA
“L’aikido sfortunatamente non rende le persone migliori” – ha ricordato il Maestro durante il seminario di Colazza. Neanche la pratica del ki purtroppo e del resto non credo sia il suo obiettivo. E’ come lavorare su un impianto di diffusione del suono: la mente è la vibrazione che si propaga nell’aria e il corpo l’impianto di emissione. Possiamo migliorare la qualità del suono, rimuovere i fruscii di fondo, ma se la musica che viene suonata è di merda…rimane di merda.
Certo, la pratica del ki favorisce comunque il miglioramento individuale: ascoltare una musica di merda che esce pulita da un buon impianto acustico è quasi sempre più gradevole che ascoltare della buona musica con un suono sporco e disturbato.
Anche sotto il profilo fisico il ki produce dei miglioramenti perché sviluppa la consapevolezza del proprio corpo, tanto è vero che molti praticanti si dedicano anche ad altre discipline che si avvantaggiavano di questa consapevolezza, come sistemi di rieducazione posturale o di allenamento funzionale.
Lo sviluppo personale legato alla pratica del ki nel passato è stato studiato e valorizzato e ha preso il nome di “ki in daily life”.
Avere un metodo per migliorarsi è gratificante, ma scherzando dico sempre che “ki in daily life” ci ha fregato a tutti. Perché ha incasellato la pratica del ki in una serie di buoni principi (per fare aikido, per parlare in pubblico, per dormire, ecc.)
Principi di buon senso certamente utili, ma che hanno indotto in tanti di noi un processo di “prototipizzazione”: per essere “giusto” devo avere questa postura, essere così, fare cosà, e così via. Ma che non hanno realmente trasformato nessuno in meglio.
Il maestro Yoshigasaki ha detto che governare sé stessi con precetti e pensieri può appartenere a persone buone, ma ipocrite. Ueshiba Morihei che lo scopo dell’aikido è “allenare la mente e il corpo e produrre persone oneste e sincere”.
Credo che il riferimento alla sincerità sia da leggersi in questo senso: agire con mente e corpo unificati permette a ognuno di essere come è. “People are people” cantavano i Depeche Mode.
Quindi non esiste un’implicazione etica nello studio del ki e del ki-aikido?
KI E AIKIDO
Qual è la differenza tra aikido e ki-aikido? La mia opinione è che la differenza fondamentale risieda nel fatto che il primo si basa su una logica di controllo di nage su ukemi, mentre il secondo lascia molta più libertà a quest’ultimo. Nell’aikido gli ukemi si torcono, volano e devono farlo perché altrimenti si espongono al rischio di essere colpiti oppure di cadere male e rompersi qualcosa. Tutto secondo uno schema preciso e preordinato.
Nel ki-aikido nage esegue una serie di movimenti (o “atti” per usare l’espressione cara in questo periodo a Sensei) finalizzati a evitare che uke possa fargli del male, ma nei quali l’elemento del controllo è minimizzato. Ukemi è sostanzialmente libero: non si deve muovere necessariamente in un certo modo. E la riprova sta nel fatto lo spazio che lo separa da nage è assai maggiore rispetto a quanto avviene nel modo di effettuare le tecniche delle altre scuole.
Se uke rimane nel gioco con nage, se continua a mantenere la sua intenzione di attacco succede che alla fine cada.
Scherzando, nage con un filo di stupore potrebbe dire, anziché “L’ho fatto cadere”, “Oh! Mi è caduto”.
Non a caso il maestro Yoshigasaki parla di “controllare la situazione” piuttosto che di controllare il partner. In alcuni casi, a livello pratico la differenza tra le due modalità è sottile e il ki-aikido è utile a imparare come gestire le situazioni senza imporsi sugli altri.
Del resto, se lo studio del ki è una liberazione personale dal controllo di pensieri ed emozioni, l’azione del ki-aikido non può avere l’obiettivo di controllare gli altri.
Questo per me il valore etico ed educativo della nostra pratica: insegna ad essere liberi, ma ci fa comprendere che nessuno è davvero libero, se non lo sono tutti.
L’IDENTITA’ DELLA SCUOLA
Trovo che l’approccio del Maestro Yoshigasaki sia molto democratico e libertario. Non è davvero uno di quelli che impone un pensiero unico! Basta vedere un po’ di esami in giro o incontrare maestri diversi per rendersene conto.
C’è chi modifica i tsuzuki waza, le sequenze, i kata, chi inventa nuovi kata, chi subisce il fascino delle altre scuole e fa un po’ di mix, chi si orienta verso la difesa personale, chi cerca dinamiche “sportive”, chi fa le tecniche come 30 anni fa…
Talvolta Beppe scuoteva la testa e commentava con disappunto: “tanto qui ognuno fa come ‘ole…” Ma in fondo forse non è un male. La diversità è ricchezza.
Potremmo dire che una delle caratteristiche principali della Ki No Kenkyukai A. I. sia proprio la diversità di approcci dei maestri che ne fanno parte.
Del resto la mia personale opinione è che nel futuro non ci sarà più una scuola con un grande maestro a fare da elemento unificante, ma rimarranno alcuni “network” di dojo amici che si ritroveranno su un terreno comune prima affettivo che tecnico.
Anche perché i tentativi di replica dell’insegnamento di sensei nel dojo danno quasi sempre pessimi risultati. Il suo messaggio non ha la facilità e l’immediatezza di quello del Maestro Tohei: la matematica delle linee e l’aikido in real life rappresentano un’evoluzione teorica in divenire che ci sta portando molto lontano, ma che richiederà tanto tempo per essere pienamente compresa e apprezzata.
Non è un caso che sia proprio lui durante i seminari a dire agli insegnanti: “in dojo non dovete spiegare quello che spiego io qui”.
E’ un modo per stimolarli a trovare dentro sé stessi qualcosa da dire, qualcosa che gli appartenga sinceramente.
Ecco, oggi credo che tutti gli insegnanti e i praticanti esperti della nostra scuola non abbiano l’obbligo di “migliorare” a livello personale, ma di continuare a cercare e trovare ragioni profonde per l’arte che praticano. Che non la sentano semplicemente come un bel giochino da samurai o una disciplina simile a tante altre, ma ne trasmettano il valore e l’unicità.
Pena la scomparsa, io credo.