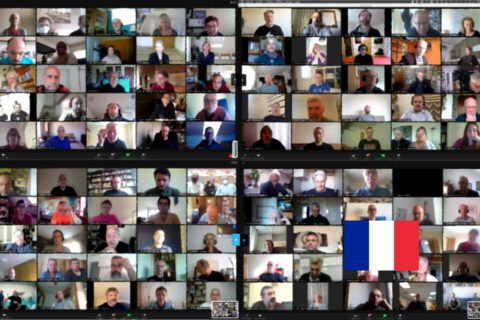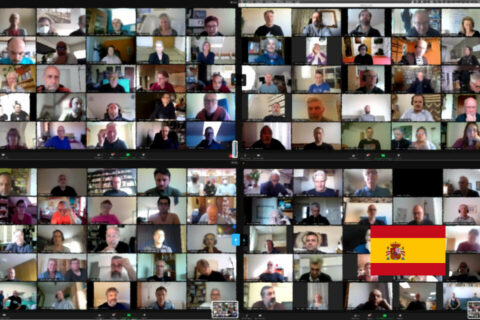Torno sul tema del mio precedente post, quello del rapporto tra aikido e competizione, perché i compagni di viaggio del blog mi hanno offerto un paio di spunti di riflessione interessanti che penso valga la pena approfondire.
Nel precedente articolo giungevo alla conclusione che la competizione in aikido è effettivamente possibile e con le medesime forme adottate in altre arti marziali (le uniche possibili forse). Per questa ragione trovo che sia decisamente superato rimanere invischiati nel dibattito “pro o contro la competizione in aikido”. Scegliere di fare le gare o di non farle è una questione esclusivamente identitaria o di “vision”, come dicono nelle aziende. E le identità che può assumere un’arte, è inutile dirlo, sono innumerevoli.
Faccio però una considerazione molto personale. Se la “vision” è semplicemente quella di “modernizzare” l’aikido con le gare e di attrarre i “ggiovani” che, si sa, la competizione ce l’hanno nel sangue…beh, mi sembra che non ci siamo evoluti molto dalle posizioni di Tomiki o di Tohei di svariati anni fa.
E’ come se stessimo rifacendo al cinema l’ennesimo reboot di Spider Man o l’ennesimo sequel-prequel-spin-off di Star Wars. Pertanto se da una parte trovo superato il confronto tra favorevoli e contrari alla competizione in aikido, dall’altro ritengo altrettanto obsoleti certi tentativi di introdurre nell’aikido la competizione sportiva.
Secondo spunto. Ho raccontato del “randori no kata” di Tomiki e ho parlato del “gioco” come elemento forse alternativo alla competizione sportiva. In un certo senso il randori, liberato da vincoli di forma, potrebbe essere un concetto assimilabile a quello del gioco.
“Randori” è un termine che viene dal judo e generalmente si traduce con “tecniche libere”. E’ utilizzato pure in alcune scuole di aikido, anche se più spesso queste ultime preferiscono definire la pratica libera “jiyu waza”. Anche noi del ki-aikido una volta utilizzavamo la parola randori, oggi qui in Europa la abbiamo sostituita con “taninzugake”, che però presuppone la presenza di un numero di ukemi superiore a uno.
Ora, indipendentemente dal numero degli uke, immaginate se durante le nostre lezioni (e fin da principianti) dedicassimo molto più tempo alla pratica libera. Un lavoro nel quale ukemi davvero alterni tutti gli attacchi e le prese che ritiene opportuni e nage non sia concentrato sul replicare fedelmente le tecniche dei tsuzuki waza o del kumi waza, ma segua liberamente il proprio istinto e la propria intuizione. Un po’ come una jam session di jazz in cui i musicisti improvvisano insieme.
Certo, stando attenti a che il tutto non diventi una rissa o una sequenza di movimenti buttati lì a casaccio. Non a caso Beppe ricordava sempre che nel randori al concetto di “libertà” si associa quello di “responsabilità”. E del resto “randori” si può tradurre sia con “tecniche libere”, ma anche con “tecniche per mettere ordine nel caos (ran)”. E mettere ordine nel caos richiede un approccio rigoroso allo studio delle tecniche stesse.
Appunto come il jazzista che prima di improvvisare si esercita con disciplina negli standard fondamentali.
Ma non potrebbe essere forse anche questo che il Maestro Yoshigasaki intende quando dice che la pratica delle tecniche nel dojo serve ad educare gli “atti” da compiere nella vita reale?