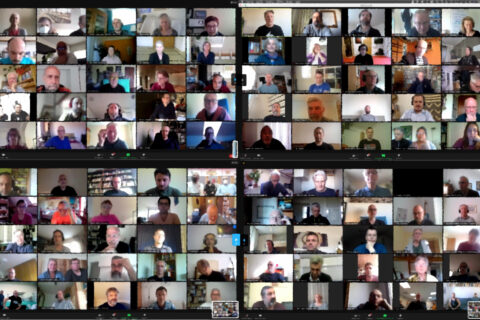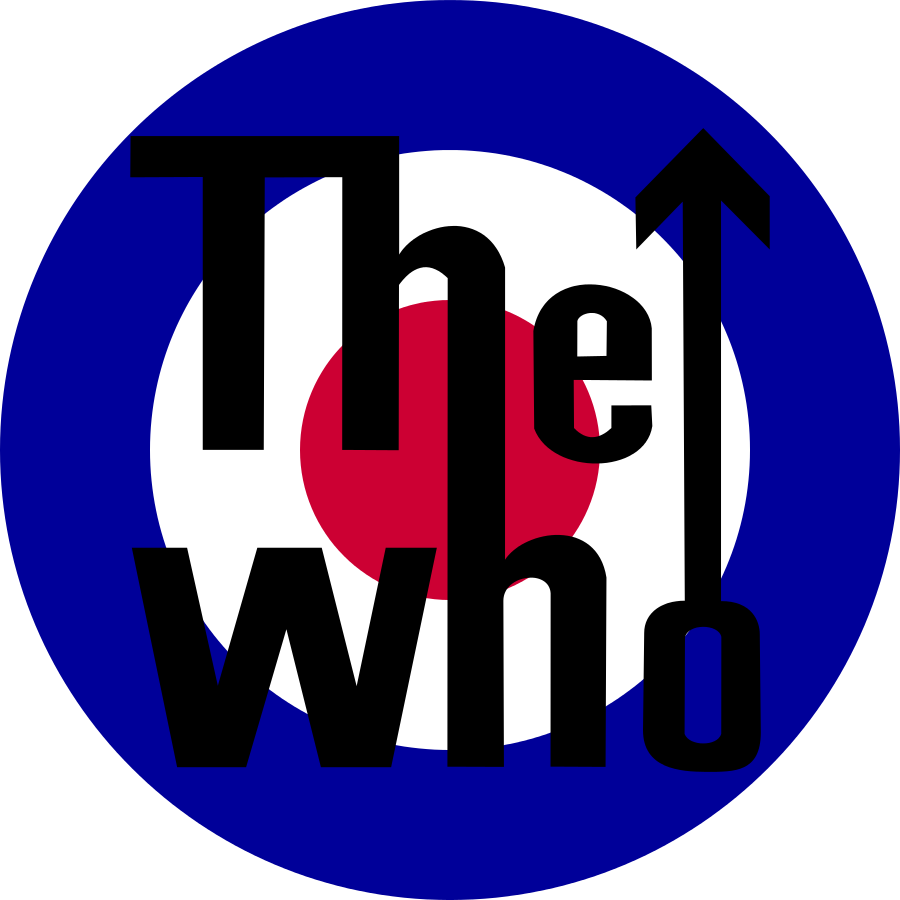Sono un fan sfegatato dei Depeche Mode da una vita. Qualche anno fa uscì uno spot della Volkswagen molto carino. Nel filmato si alternavano scene di persone diverse alla guida della nuova Golf, sempre con in sottofondo People are people dei DM, solo in cover e versioni di volta in volta differenti. Quindi la cover country viene canticchiata da un allegro signore con il cappello da cowboy, una versione suonata da un carillon accompagna dolcemente una famiglia in gita, mentre il remix dance fa da colonna sonora alla serata di due ragazze in tiro. E così via, fino a quando la versione originale non irrompeva sull’inquadratura di un braccio tatuato fuori dal finestrino per spostarsi subito dopo al posto di guida sul profilo sornione e malandrino di Dave Gahan.
Il messaggio èchiaro: le persone sono tutte diverse, ma la Golf va bene per tutti. Perché in certo senso è “universale”, come la musica dei Depeche Mode.
Che cosa c’entra con lo scorso fine settimana aikidoistico direte voi? Ecco, il mini-tour che ho fatto di tre tatami in due giorni, fatto non solo di aikido, ma anche di buone chiacchiere davanti a un bicchiere di whisky, mi ha fatto tornare in mente quello spot. E mi ha lasciato addosso esattamente la stessa suggestione di “universalità”.
Venerdì 29 sono arrivato in treno verso le diciannove circa in una Vercelli umida e completamente avvolta nella nebbia. “Questa è la vera Vercelli” ha commentato ridendo Francesco, “non quella che vedi ad aprile”.
Nonostante il raffreddore, l’occasione di poter fare lezione al dojo Ronin mi è stata assai gradita. Ho cercato di dare un taglio più personale possibile proponendo di lavorare sull’attacco multiplo, Taninzugake, elemento che cerco ad ogni occasione di praticare e sviluppare perché lo ritengo intimamente legato al nostro modo di intendere l’aikido e che sento molto mio.
Sono rimasto piacevolmente colpito dall’atteggiamento e dal buon livello degli allievi (del resto non potevo dubitarne). Ma soprattutto dal fatto che il loro modo di muoversi evidenziasse un’impostazione assai affine alla mia.

Il mattino dopo la nebbia ha lasciato posto a un bel sole e con Francesco siamo partiti per Torino, alla volta del seminario del Doshu.
I temi cari a Sensei nell’ultimo periodo sono tornati puntuali e trovato particolarmente interessante la sua ricostruzione del fatto che il concetto di “Do” abbia nella storia giapponese una genesi religiosa. Nasca cioè nell’ambito della religione (del resto anche “Shin-to” vuol dire “la via di Dio”) e si estenda per il tramite dello zen prima al mondo dell’arte in generale e poi alla fine dell’Ottocento a quello delle arti marziali in particolare.
Pertanto, il dojo, il “luogo ove si pratica la via”, richiede un rispetto e un comportamento analoghi a quelli che si terrebbero in un luogo di culto. Ora, la caratteristica peculiare del nostro “culto” è quello di essere assolutamente universale e ovvero di non imporre dogmi o dittature culturali. Se Do è “la via”, si tratta di un percorso che si fa a piedi e non – ad esempio – su un treno, dove si sale su e si viene portati in giro da qualcun altro. L’aikido è un cammino, il Doshu lo ha detto più volte, ma non vi è la pretesa di indicare il tragitto o la destinazione. Come insegnare a un bambino a muovere i primi passi e dopo lasciarlo libero di andare dove vuole. In questo approccio risiede a mio avviso il valore più alto della nostra pratica e il senso della sua universalità: essa è aperta a tutti e a nessuno richiede requisiti particolari o pretende di trasformarne la vita.
È una visione davvero lontana da quello del ki-aikido che ho iniziato a praticare molti anni fa, caratterizzato da regole e principi per ogni cosa (praticare, parlare in pubblico…dormire!) e che pretendeva di rappresentare la “Via dell’Universo”.
La pratica mette in contatto il nostro corpo con quella che potremmo definire la nostra “mente originale”, ovvero una mente libera da pensieri, sentimenti, emozioni e così via. Ci permette quindi di capire come funziona o funzionerebbe il nostro corpo libero da condizionamenti e allo stesso tempo di percepire globalmente i medesimi condizionamenti. Personalmente trovo che sia come cancellare una lavagna per poter scrivere sulla superficie ciò che riteniamo più giusto o semplicemente ciò che è nelle nostre possibilità.
E se siamo nel diritto di scrivere la nostra storia sulla nostra lavagna, ognuno è libero di fare lo stesso. “Creare la propria vita è un diritto dell’uomo” ci ha ricordato Sensei, “esattamente come mangiare o bere”. Ovviamente senza andare a discapito della vita delle altre persone, ma rispettandola per poter vivere in armonia con le altre persone.
L’educazione alla libertà e al rispetto trova il suo corrispettivo fisico nella pratica del tehodoki, vero e proprio fondamento dell’”aikido nella vita reale” del Maestro Yoshigasaki. Nel suo libro Sensei spiega come “tehodoki” indichi “l’insegnamento per i principianti”, ma la traduzione letterale del termine sia “liberarsi dalle prese”.
In sintesi, la prima cosa che un principiante dovrebbe imparare è come diventare libero.
Ora, è importante comprendere che le tecniche del tehodoki per liberarsi da prese ai polsi, alle braccia o alle spalle non consistono in movimenti nervosi o scattosi (in cui ad esempio si tira o si “strappa”), ma sono dolci e determinati contemporaneamente. E soprattutto permettono di sfuggire alla presa di ukemi perché prima del movimento di evasione vero e proprio ne cambiano la mente. O, in una parola, la “guidano”.
Se nage, bloccato ad esempio al polso, semplicemente ritraesse via la mano con uno scatto repentino potrebbe anche avere successo nel “rompere” la presa, ma la mente di uke rimarrebbe inevitabilmente sempre su di noi. Di conseguenza nessuno dei due sarebbe granché libero.
Questo è “aikido nella vita reale”.
Durante l’allenamento però questa capacità non è semplice da affinare: se l’obiettivo è semplicemente liberarsi, diventa difficile apprezzare se ciò avvenga davvero a seguito di un cambiamento della mente di ukemi. Per questo motivo, nel dojo, ukemi viene fatto cadere. La caduta nel dojo è “un risultato fissato in un ambiente fissato”. Garantisce quindi una sorta di “oggettività” nella valutazione della bontà della tecnica. Proiettare ukemi permette a nage di sviluppare la sua abilità a disimpegnarsi dalla presa o dall’attacco cambiando la mente del partner e se uke sarà stato guidato correttamente, cadrà volentieri.
E questo è “aikido nel dojo”.

La serata di sabato è trascorsa nuovamente a Vercelli davanti a una buona cena giapponese, tra ricordi del passato, riflessioni sul futuro e considerazioni su quanto la vita di ogni persona sia eccezionale e spesso piuttosto incasinata.
Il mattino dopo un tempo nuovamente umido e nebbioso ha accompagnato il nostro viaggio verso l’appuntamento annuale della lezione istruttori della UISP.
Quest’anno gli insegnanti che si sono alternati sono stati Davide Rizzi di Bologna, Piero Messeri di Prato e lo Shihan Mario Peloni. Ciascuno dei tre ha cercato di fornire ai partecipanti dei validi strumenti per l’insegnamento, basati sulla loro esperienza personale e improntati alle loro peculiarità. Davide ha proposto lo studio degli hitori waza in coppia come strumento utile a migliorare non solo il lavoro di nage, ma anche quello di ukemi. Piero, da esperto maestro di balli di sala qual è, ha focalizzato la sua attenzione sulla postura, sul rapporto tra le gambe e la parte superiore del corpo e sulla posizione delle spalle. Mario infine ha proposto una bella sequenza nella quale le tecniche di jodori e jonage si mescolavano e i ruoli di nage e ukemi si scambiavano.
Onestamente non posso dire che tutto quello che ho visto a Modena mi sia piaciuto o mi abbia convinto il modo in cui è stato detto, ma non importa. Proprio a Torino il Maestro Yoshigasaki ci ha ricordato come apprendere con amore verso i nostri maestri anche dalle cose che non condividiamo sia una delle prerogative di un buon praticante di aikido.

E del resto:
“People are people so why should it be?
You and I should get along so awfully”
(“Le persone sono persone, quindi perché io e te dovremmo andare così terribilmente d’accordo?”) Ma questo non vuol dire che non si possa volersi bene e imparare gli uni dagli altri.