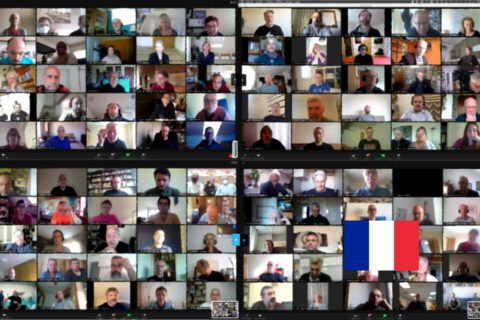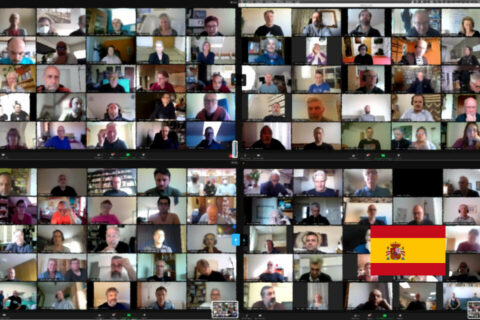Sono andato a provare la capoeira all’inizio del 2001. Al tempo non ne sapevo molto. Da ragazzo avevo letto i romanzi di Jorge Amado, in alcuni dei quali è presente, anche se con contorni poco definiti, la figura del capoeirista. E poi l’avevo vista negli spettacoli del ristorante brasiliano di Firenze, il Maracanà, durante i quali aitanti ragazzoni neri si intrecciavano in lunghe sequenze di meia lua de compasso.
A quel tempo le possibilità e le disponibilità di materiale scritto e video su internet erano assai più scarsa di oggi, ma non si stava peggio, anzi! Le discipline marziali avevano un elemento di mistero e di fascino che ti portava a volerle sperimentare direttamente. E non solo a fartene un’idea guardando un po’ di filmati di dubbia qualità su YouTube nell’ordine stabilito da un algoritmo sulla base di criteri sconosciuti.
Ho praticato con passione capoeira per oltre tre anni, arrivando a dividere i miei allenamenti con l’aikido su cinque giorni la settimana. Come capoeirista non ero un granché, però mi divertivo molto.
Il mio ultimo insegnante è stato un ragazzo che veniva a Firenze due volte la settimana, pensa un po’, da Bologna. Un segno del destino? Forse. Un maestro italiano e non brasiliano, fatto piuttosto sorprendente in quegli anni. E poi bravissimo: dotato finalmente di una didattica davvero solida e strutturata, al contrario di quella “istintuale” che caratterizzava la maggioranza degli altri maestri che avevo incontrato.
Ma soprattutto un capoeirista che a Bologna praticava ki-aikido al Centro ASIA!!!
C’erano tutti gli elementi perché lo trovassi simpatico. (Senza soffermarsi sul fatto che nelle playlist che accompagnavano il riscaldamento capitava che ti spuntasse Rio dei Duran Duran…)
È stato quindi con molto piacere che qualche anno fa a Bologna ho ritrovato casualmente Federico Nicolis Preto. Ho iniziato a seguirlo su Facebook e siccome la capoeira è per me un po’ come un tarlo, mi è venuta la voglia di indagare con lui vecchie e nuove suggestioni sulle differenze e le somiglianze con l’aikido. Così è nata l’idea di questa chiacchierata.

C. Ciao Federico, grazie innanzitutto per aver accettato questa intervista per KNN. Giusto come introduzione, come hai iniziato a praticare capoeira?
F. Assolutamente per caso. Quando mi sono trasferito a Bologna per studiare avevo voglia di ricominciare a muovermi. Ho sempre fatto judo durante gli anni dell’infanzia, ma quell’anno la squadra universitaria non si è formata e allora ho cercato qualcos’altro. Sono andato a provare dopo aver visto un volantino, banalmente, senza avere idea di che cosa si trattasse.
C. E com’è che hai iniziato a fare aikido?
F. Cercavo una pratica che mi facesse capire in maniera più sottile il mio corpo. La capoeira che facevo all’epoca era abbastanza rozza e superficiale.
C. Però poi ti sei talmente appassionato che hai deciso di farne materia per la tua tesi di laurea…
F. Sì, quella è stata più che altro la scusa per andare in Brasile “a spese del contribuente” (ride). Scherzi a parte, è stato ovviamente un momento di grossa svolta. Rimanere per sei mesi in Brasile mi ha esposto ad aspetti della capoeira che in Italia non potevo neanche lontanamente sospettare.
C. Di che anni parliamo?
F. La prima volta che sono andato in Brasile è stato nel 2000.
C. È vero che sei stato il primo professor italiano di capoeira?
R. Non lo so. Professor direi di no. Probabilmente sono stato il primo insegnante di capoeira ad avere un lavoro lontano dai propri maestri: io insegnavo qui, ma i mei maestri erano in Brasile. Sicuramente mestres brasiliani che erano in Italia già da anni hanno avuto “sotto di sé” degli istruttori italiani da prima che diventassi insegnante io.
C. Puoi raccontarmi qualcosa sulle origini della capoeira?
F. È molto complesso parlare di “origini” della capoeira. A differenza della maggioranza delle arti orientali, per le quali esiste una corposa documentazione scritta, magari asserente una presunta genesi millenaria che non esiste, però, insomma, almeno riportante una genesi, delle origini della capoeira se ne sa davvero poco. La leggenda per la quale gli schiavi fingevano di danzare per allenarsi a lottare è del tutto priva di qualsiasi riscontro, anche perché, per quanto abili potessero diventare, si sarebbero trovati ad affrontare gente a cavallo armata di fucili e quindi assai difficile da sopraffare a calci.
Diciamo che la capoeira come la conosciamo oggi nasce probabilmente nell’800 nei bassifondi del porto di Bahia e a pensarci bene è facilmente comprensibile essendo quella del porto, da sempre, una comunità caratterizzata da scambi e contaminazioni culturali, ma pure una comunità fondamentalmente violenta. Poi, come tutta la popolazione povera di Salvador, ha una fortissima tradizione legata alla musica e alla danza. In un ambito del genere la capoeira rappresentava un “passatempo” in cui tutti questi elementi, lotta, danza e musica venivano inclusi contemporaneamente. Lo stesso atto di mettersi in cerchio per formare la roda, battere le mani e cantare è tipico della tradizione del samba di Bahia.

Sicuramente la capoeira come la conosciamo oggi ha degli antenati marziali, ma allo stesso tempo la parte rilevante consiste proprio in questo momento ludico che la colloca in uno spazio “poco chiaro”, sospeso tra danza e lotta. Uno spazio che viene costantemente ri-negoziato, così come le sue regole, che vengono costantemente riscritte. Quando inizio a giocare con qualcuno infatti, non so se ci sorrideremo o se proveremo a metterci ko o ancora se faremo qualcosa solo per il pubblico che ci guarda. Non è detto e non è scontato. È una conversazione e non conosciamo in anticipo quale tono prenderà.
C. Il mio maestro, Beppe Ruglioni era particolarmente affascinato dalla capoeira e trovava che il “dialogo” tra i due giocatori, fatto di attacchi e contrattacchi, fosse del tutto analogo alla nostra pratica che vede contrapposti jo a bokken. Questo è sicuramente vero, ma nella mia esperienza non esaurisce la vicinanza tra le due discipline.
All’epoca infatti, trovavo la capoeira fosse assolutamente complementare all’aikido, nel senso che mi sembrava avesse tutto ciò che l’aikido ai miei occhi non possedeva. Intendo dire: le tecniche principali sono di calcio, mentre nell’aikido di calci ne studiamo solo un paio; l’aikido ha le prese ai polsi, alle braccia, alle spalle, mentre nella capoeira le prese non ci sono; la capoeira si pratica a coppie in una sorta di “duello”, ed è una logica che nell’aikido non esiste e infatti noi studiamo taninzugake, ovvero l’attacco di più persone contro una sola; giocare la Capoeira richiede una certa “malizia” (la malandragem) che nel contesto dell’aikido, caratterizzato dall’attenzione all’etichetta e alle “buone maniere”, non dovrebbe trovare luogo. C’è poi questo fatto del mettere le mani in terra, mentre nell’aikido le mani rimangono sempre in alto, e così via.
Due discipline che vedevo opposte quindi, ma non poi così lontane. Ad esempio, proprio rispetto al discorso delle mani, il nostro primo test, quello fondamentale nella scuola di Yoshigasaki, prevede di stare in piedi con le braccia distese verso l’alto. E il Maestro stesso ci ha invitato più volte a vedere questa forma come una sorta di verticale rovesciata.
Nella capoeira poi il contatto è generalmente assente e quanto avviene nella roda tra i due giocatori non è mai una gara, tipo quelle di judo o di karate con obblighi, punteggi, ammonizioni, ecc. E anche nella maggioranza delle scuole di aikido, compresa la nostra, gare non se ne fanno.
Pure rispetto alla “malizia”, è vero che sul tatami non esistono occasioni di sfida e di confronto aperto, ma la rivalità tra i praticanti esiste eccome! E talvolta si manifesta in modo prepotente, ad esempio quando vogliamo cadere a ogni costo ukemi o gli applichiamo con decisione eccessiva una contro articolazione. Ma anche più subdolo, ad esempio quando ukemi fa ostruzionismo a nage in modo sciocco oppure gli evidenzia qualsiasi occasione in cui – appunto – potrebbe colpirlo facilmente.

F. Mi allaccio a una delle cose che hai detto perché è interessante. Capisco quello che dici rispetto alla differenza di contesto e alle “buone maniere” e in parte è vero. Però, a mio avviso le cose stanno esattamente al contrario.
La capoeira non ha regole, ha solo buone maniere.
Non esiste nulla che il giocatore non possa o non debba fare. Però esistono delle conseguenze. Come dicevo prima, il gioco è come una conversazione: io ti parlo con gentilezza, tu mi rispondi in modo sgarbato. Starà a me valutare se risponderti per le rime, se continuare a essere gentile oppure non aver più voglia di esserlo e decidere se e come acuire il momento di scontro. L’interazione tra le due persone è l’elemento centrale, esattamente come nell’aikido, solo che viene sviluppata in modo diverso. Un “esercizio” che si fa nella capoeira infatti è quello di “testare” la pazienza dell’altro, non necessariamente utilizzando la violenza, ma mostrando la possibilità di questa violenza. Diciamo che la capoeira di oggi non contempla lo scopo di provocare un danno, ma quello di mostrare la possibilità del danno. È questo lo spirito del gioco, se vogliamo ridurlo ai minimi termini. Il giocatore crea delle situazioni nelle quali potrebbe far male all’altro, ma dimostra la superiorità mentale necessaria per controllarsi. Cerca di provocare un attacco o una mossa falsa da poter “capitalizzare”, magari sbilanciando l’altro con uno sgambetto.
C. Quanto dici sulla scelta di una condotta più o meno gentile mi fa venire in mente che anni fa il Maestro Yoshigasaki disse che l’aikido che ci insegnava come un piatto dal sapore “neutro”. Stava a noi decidere a seconda della situazione se e quanto peperoncino aggiungere.
F. Per andare invece sul tema dei calci, la capoeira ha avuto un grosso sviluppo in Brasile grazie al turismo. I calci sono sempre stati centrali, ma sono diventati ancora più centrali appunto con l’avvento del turismo internazionale, rappresentando l’elemento estetico più spettacolare da valorizzare per il pubblico. Qualsiasi maestro anziano ti dirà che l’efficacia marziale della capoeira non deriva dai calci, ma da tecniche come le cabeçadas, le testate, e le spazzate, gli sgambetti. I movimenti di squilibrio insomma.
C. Quindi anche la storia che i calci si sono sviluppati perché gli schiavi erano legati e non potevano usare le mani…
F. Quello è folclore. Anche perché, vedendo dei filmati degli anni ’30-40, ci si rende conto che non era presente una grande destrezza nell’uso dei calci rispetto ad oggi. Sicuramente i praticanti erano assai più avvezzi di noi alla violenza e quindi non ho dubbi sulla pericolosità di uno di quei calci che noi definiremmo “mal fatti”, ma la qualità estetica che abbiamo oggi allora era sconosciuta.
La capoeira del resto, era un’arte che nasceva per la strada: i giocatori non si chiudevano in monasteri o dojo ad affinare le loro tecniche. Era un passatempo. Volendo infatti andare indietro nel tempo a cercare un fondamento marziale nella capoeira, essa è riconducibile alla lotta con il rasoio o con il coltello e anche in un caso del genere, se mi trovo ad aver a che fare con qualcuno armato di coltello, difficilmente privilegerò un calcio come tecnica di difesa.

C. Infatti avevo letto che era stato Mestre Bimba a sviluppare i movimenti di calcio, integrando elementi di arti marziali orientali…
F. Questo è un tema molto dibattuto. Anche gli stessi allievi di Mestre Bimba, suo figlio incluso, non concordano con questa opinione. E in effetti nella sua capoeira, la Capoeira Regional (anche se oggi viene definita “Regional” un sacco di roba che non ha a che fare con la scuola di Mestre Bimba), sono presenti gli stessi elementi della cosiddetta capoeira “tradizionale”. Solo una volta ho visto applicare una specie di leva che poteva assomigliare a una di quelle dell’aikido.
C. Beh, ricordo che già quando praticavo io, sentivo parlare di maestri che introducevano elementi del Brasilian Jujitsu che appunto in Brasile è molto popolare.
F. Sì, judo e jujitsu sono arrivati molto presto in Brasile, che ha avuto una forte immigrazione dal Giappone. Per cui non ci vedo nulla di strano.
C. Tornando al rapporto tra le due arti, qual è stato per te il valore della pratica dell’aikido nello studio della capoeira?
F. La capoeira storicamente ha una didattica abbastanza limitata. In Brasile è normale impararla da bambini, per imitazione. È ovvio quindi che le esigenze di un europeo adulto che si approccia alla pratica siano diverse quanto a modalità di apprendimento. Adesso le cose stanno un po’ cambiando, ma all’epoca ho trovato tantissimo beneficio nella pratica dell’aikido, che mi permetteva di educare il mio corpo, di “dare un nome” alle cose che il mio corpo faceva. Di percepirlo in un modo che la capoeira di allora non mi permetteva.
C. Sì, questa è una grande qualità che rivendico per l’aikido in generale e per il ki-aikido in particolare. Il ki-aikido non sviluppa performance fisiche eccezionali, ma mediante lo studio dei test dà degli strumenti di consapevolezza del proprio corpo che sono eccellenti. Aiuta a “sentirsi” meglio, in un duplice significato. Non a caso negli anni vari praticanti che ho conosciuto si sono avvicinati a discipline particolarmente impegnative dal punto di vista della coordinazione e dello sviluppo fisico, come ad esempio il Calisthenics o il CrossFit.
F. Sì, anche solo nella gestione dell’infortunio a me ha dato tante cose. Un miglior ascolto di me stesso mi ha portato a cambiare di molto il mio modo di lavorare quando sono troppo stanco o usurato. E di conseguenza ho notato davvero un grosso cambiamento – in positivo – nella frequenza delle volte in cui mi capita di farmi male.
C. Vi è poi l’aspetto della non-collisione. Il Maestro Yoshigasaki ha detto che lo scopo dell’aikido è creare delle situazioni in cui l’attacco non succede. Da quanto mi dici, sembra che lo scopo della capoeira sia al contrario creare delle situazioni in cui l’attacco – nella fattispecie il mio – “può” succedere.

F. Diciamo che spesso io paragono la Capoeira agli scacchi, per come la si gioca. Io ho necessità che l’altro attacchi, è necessario per entrambi. Sarebbe come se negli scacchi uno dei due giocatori si rifiutasse di muovere, si perderebbe il senso del gioco stesso.
C. Mentre l’aikidoka, al contrario, vorrebbe proprio evitare di giocare…
F. Credo che la cosa interessante rimanga comunque la ricerca del non contatto e appunto della non collisione. In capoeira parare o bloccare un attacco è considerata l’ultima delle opzioni e comunque sempre la più scadente, di un valore ben più basso rispetto a una schivata. Il capoeirista non deve farsi trovare dove l’attacco sta per arrivare e da questo puto di vista uno dei punti di contatto, dei possibili scambi che vedo con l’aikido è proprio il lavoro sulla gestione dello spazio.
Da quanto ho avuto modo di osservare infatti, nell’aikido il lavoro sul corpo dell’altro viene sempre dopo quello sull’intenzione, sulla direzione. Prima di tutto è essenziale comprendere dove avverrà l’attacco, poi non farsi trovare e condurre, no?
C. Certo. Rimanendo sulla metafora degli scacchi, l’aikido non è pensato per rimanere confinato nello spazio della scacchiera. L’aikidoka vuole uscire da quel confronto e si addestra a gestire attacchi che possono arrivare da più direzioni nel momento in cui si muove per “evadere”.
facebook.com/capoeirapalmaresbologna/
capoeirapalmares.it