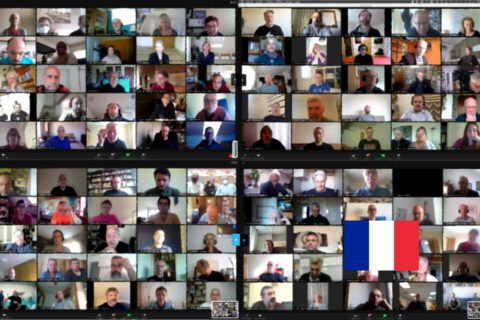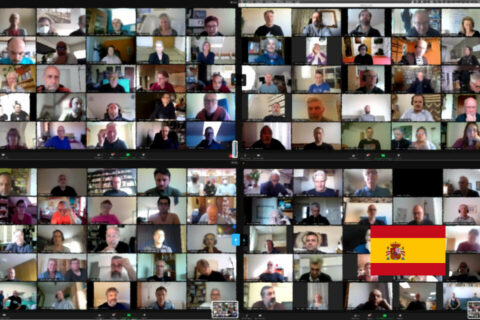La seconda parte dell’intervista al Maestro di capoeira Federico Nicolis Preto. Qui la prima parte.
C. Un altro elemento comune tra aikido e capoeira è rappresentato secondo me dal cadere. Anche nella capoeira infatti si cade e nella nostra scuola si dice che la caduta è il modo per “cambiare la mente” di chi ci attacca in un modo definitivo. Cioè, definitivo rispetto al singolo attacco, non che l’aggressore va giù e non si rialza più, eh…
F. … si spera! (Ride).
C. Ogni tecnica infatti può essere letta come una sequenza di singoli momenti di elusione dell’attacco. Intendo dire: tu provi a colpirmi o a prendermi, io faccio un movimento che mi permette di evitare l’attacco, tu però mantieni l’intenzione di attaccarmi, io allora creo un’altra forma di “elusione”, e poi un’altra. Evito, evito e poi alla fine…
F. … te lo spiego.
C. Esatto. E poi alla fine vai in terra. E quel momento rappresenta per ukemi una sorta di trasformazione, una specie di “morte e rinascita”. Esiste un significato analogo nella caduta della capoeira?

F. La premessa fondamentale è che il capoeirista lavora per non cadere. A terra vanno solo piedi, mani e testa. Il resto è un errore o una momentanea “sconfitta”. Lo dico con molte virgolette perché parlare di vittoria o sconfitta in capoeira è assolutamente sbagliato. Bisogna poi ricordare che la pratica avviene in pubblico, davanti a un gruppo di persone, quindi anche il “come” metto per terra l’altro ha un significato particolare. Intendo dire: stiamo giocando insieme, tu diventi aggressivo e ti scopri, io con una piccola spazzata, uno sgambetto, ti faccio cadere. Se cadi bene, tutti rideranno. E tu potrai reagire arrabbiandoti ancora di più e cercare vendetta oppure facendoci su una risata insieme agli altri e comprendendo di esserti lasciato trasportare a fare una mossa insensata. Quello può essere in effetti un momento di trasformazione, di apprendimento.
Allo stesso tempo, se ti metto per terra in modo eccessivamente brusco sono io a fare una brutta figura. Non è una vittoria, quella.
I verbi che si usano nella capoeira sono interessanti perché è rarissimo sentire il verbo lutar, lottare. Il verbo più comune oggi è giocare, mentre quello più tradizionale è vadiar che vuol dire più o meno “andare a spasso”, “ingannare il tempo”. La capoeira nasce come passatempo, come una ricreazione. Era il modo di impegnare la pausa dei marinai, degli scaricatori del porto e non qualcosa fatto con uno scopo preciso. Ovviamente le abilità sviluppate potevano essere “esportate” anche in altri contesti, ma non era comunque quello il fine.
Io la paragono spesso a un gioco infantile come nascondino oppure giocare a prendersi. A fine giornata non si fa – o almeno ai miei tempi non si faceva – la classifica di quelli che avevano trovato più volte gli altri e che per questo erano da considerarsi i vincitori del giorno…
C. …e se nel gioco eri troppo crudele finiva che passavi male di fronte agli altri.
F. Esatto. Il limite del gioco è stabilito dalla comunità. E comunità differenti possono darsi regole estremamente diverse.

C. Un’altra domanda che può allacciarsi a quanto mi hai appena detto. Ci si riferisce di solito all’aikido e alla capoeira come “arti” marziali. Ultimamente il Maestro Yoshigasaki sottolinea però con forza come l’ai-ki-do sia appunto un “Do”, una “via” di miglioramento di sé stessi e del mondo. È vero che la capoeira nasce come passatempo degli operai del porto, ma mi sembra che oggi abbia assunto anche dei tratti che la rendono una sorta di stile di vita. Si può dire che esiste un “Do” della capoeira?
F. È una questione interessante. Molte persone infatti parlano della capoeira come di una filosofia di vita, ma per me la faccenda è estremamente delicata, in quanto la capoeira di fatto ti insegna a fregare l’altro, a irriderlo. Quindi non so se è proprio la filosofia di vita che vorrei insegnare ai miei figli.
C. Però, sai come si dice a Firenze, “tre volte bono si chiama bischero”…
F. Certo, essere svegli è un’altra cosa. Però, mentre l’aikido nasce con l’obiettivo di dare dei valori, un’educazione per la vita, la capoeira addestrava ad un tipo di vita ben preciso, che è quello dei bassifondi. Quindi, fondamentalmente era un’educazione alla paranoia. Gli insegnamenti che i vecchi maestri danno sono di ordine assolutamente pratico: “guardati le spalle”, “apri la curva prima di entrare in un vicolo per vedere se dentro c’è qualcuno”, “in un luogo pubblico siediti con le spalle alla parete”, “guarda in faccia il barista per fare caso se entra qualcuno nel locale”. Una sorta di manuale di “sopravvivenza urbana”.
La differenza rispetto all’etica o all’integrità dei samurai quindi è profonda. Lo stesso concetto di onore in capoeira è estremamente vago; ho sentito più di una volta grandi capoeiristi vantarsi di aver svicolato abilmente per evitare il confronto con altri maestri nei casi in cui non erano particolarmente in forma o comunque erano certi che l’altro li avrebbe fatti sfigurare. Ora, anche Musashi ne usava di sotterfugi, ma l’idea del “duello cavalleresco” non esiste. Il principio fondamentale è vivere per provarci un altro giorno.
C. Ci sarebbe molto da dire sui concetti di onore e integrità che caratterizzano l’etica dei samurai. In larga parte, per come è conosciuta oggi, è una ricostruzione dell’otto-novecento legata alla restaurazione Meji. Una volta il Maestro Yoshigasaki scherzando ha detto che “solo i samurai molto stupidi hanno fatto seppuku”. D’altra parte, è vero che siamo molto lontani ad esempio da Jigoro Kano, un professore universitario che crea il judo come forma di allenamento, ma anche come metodo di sviluppo delle virtù civiche.
F. Senza ombra di dubbio. D’altronde esistono anche dei valori assolutamente positivi da non dimenticare. Quello della comunità innanzitutto. La capoeira non si fa da soli e non si fa neanche in due a dire il vero. Servono persone che suonino, che cantino, che battano le mani. La musica stessa crea un’interazione continua tra i due giocatori e il cerchio di persone intorno. Le canzoni commentano quanto avviene durante il gioco e il ritmo cambia seguendo il movimento.
C. I tuoi allievi che cantano e suonano nelle rodas riescono a fare quanto dici?
F. È un lavoro in corso, ma sempre più praticanti stanno apprendendo il portoghese. Chiaramente è assai più facile (per gli italiani in particolare) che imparare il giapponese. La parte del canto e del commento è cruciale perché tradizionalmente il canto veniva utilizzato anche come elemento di sfida. Adesso questa cosa si è un po’ persa anche in Brasile, ma una volta i due giocatori potevano sfidarsi scherzosamente anche “a quartine”, un po’ come succede nell’hip hop o tra gli stornellatori dell’Appennino. Altre volte invece era usato come modo per fare pace se il confronto era stato troppo acceso. Musica e canto contribuiscono in maniera essenziale alla trasformazione della roda in uno spazio “altro” rispetto all’esterno. Un po’ come è o dovrebbe essere un dojo.

C. Indubbiamente. Proseguendo sul tema della musica, parliamo invece dell’elemento della danza. “Bu” in giapponese viene generalmente tradotto come “guerra” (bu-shi, bu-do, e così via). L’ideogramma “Bu” utilizzato in ambito marziale è formato internamente da due ideogrammi: “fermare” e “lance”. In virtù di questo molti ritengono che il senso corretto non sia “guerra”, ma “fermare la guerra”. Tralasciando queste disquisizioni, “Bu”, scritto diversamente, è anche “danza”, come bu-to o ka-bu-ki. E non a caso il legame tra danza e arti marziali è molto stretto. Esiste infatti un vecchissimo filmato di Ueshiba Morihei che insegna i movimenti con la spada a delle ballerine di danza tradizionale giapponese. Oppure penso al Muay thai, dove gli incontri vengono preceduti da una danza rituale, la Ram Muay.
Nessuna arte marziale però ha un legame così stretto con la danza come la capoeira.
F. È stato uno dei miei grossi interessi e all’università avrei voluto avere modo di lavorarci di più, purtroppo non è stato possibile. Una cosa che ho notato guardandomi attorno, da grande appassionato di arti marziali e di discipline del corpo in genere, è che ogni cultura tende a muoversi per la danza e per la lotta in modo assai simile. Nel periodo in cui praticavo aikido mi è capitato di vedere uno spettacolo di teatro No e sono rimasto stupefatto da quanti punti di contatto ci fossero. Lo stesso si può dire delle danze e delle arti cinesi e tailandesi: è proprio il modo di “pensare” il corpo ad essere identico. Alla corte di Versailles il maestro di spada e il maestro di danza erano la stessa persona; non per nulla nella danza classica e nella scherma la posizione dei piedi è la stessa.
Però, non ha molto senso parlare di danza nel caso della capoeira. Ovviamente ci si muove a tempo con la musica e si interpreta la musica. Peraltro, anche nel Muay Thai si suona dal vivo e so anche di un’arte indonesiana che viene accompagnata dalla musica, almeno durante gli allenamenti. Ma anche nell’aikido, da ciò che ho visto praticando con il Maestro Bertossa, il ritmo è fondamentale. Non esiste tecnica senza ritmo.
C. Ti dirò che è stato uno degli elementi che mi ha conquistato quando ho iniziato a praticare ki-aikido, una vera magia. L’uso del ritmo caratterizza la nostra scuola o almeno le altre non lo esprimono in maniera così evidente. Creare un ritmo con un movimento – anche impercettibile – del proprio corpo, nel momento in cui veniamo attaccati, è il primo modo per cambiare la mente dell’altro, per andare insieme.
Io ho un senso del tempo particolarmente sviluppato (Giorgia ridacchia). Ok, scherzo, però penso di poter dire che l’unico ritmo che ho capito nella mia vita è stato appunto quello del ki-aikido. E in questo senso ritengo di essere stato molto fortunato perché era un tratto che il mio maestro, Beppe Ruglioni, aveva particolarmente innato. Io l’ho appreso, ma non è stato istintivo. E comunque nell’aikido il ritmo non è dato da uno strumento che suona oppure dal battito delle mani: si crea con l’attacco dell’altro, si crea nella situazione.
F. Beh, però non è poi così diverso. La mia tesi è stata in etnomusicologia e ti posso dire che in origine tutti i ritmi nascono dal movimento del corpo: se non abbiamo disabilità particolari, camminiamo battendo un ritmo regolare. Nelle danze africane ciò che fanno i tamburi lo fanno i piedi e non so che cosa sia venuto prima. Perciò non credo abbia molto senso distinguere il ritmo dei corpi da quello creato dalla musica.
C. L’ultima domanda: l’influenza della religione. Da un certo punto in poi della sua vita Ueshiba Morihei aveva aderito a una setta shintoista e questo ha contribuito in maniera profonda a creare la dimensione mistica dell’aikido. Lo Shinto è una religione animista che nei secoli si è “mescolata” con le altre religioni giunte in Giappone, in primis ovviamente il buddismo. Mi chiedevo quanto è effettivamente presente nella capoeira l’elemento mistico o religioso. Sto pensando in particolare al Candomblé, che è essa stessa una religione animista.
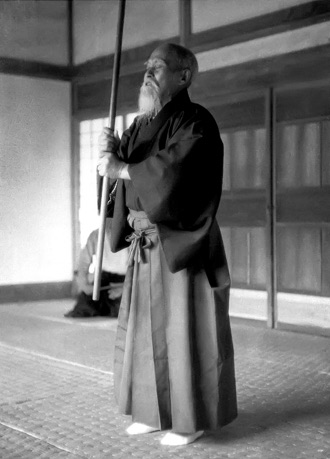
F. Anche questo è un tema interessante. Innanzitutto, è opportuno fare una distinzione. L’aikido nasce da una persona specifica, dalla sua esperienza. La capoeira non ha un “fondatore”. Ha queste due numi tutelari, Mestre Bimba e Mestre Pastinha, ma a livello di genealogia capoeiristica non tutti discendono da loro. Personalmente, io stesso pratico una capoeira che non deriva dalla loro tradizione. Sono stati comunque coloro che l’hanno portata nell’era moderna. Due divulgatori, ma non due fondatori. E, nel caso di Mestre Bimba, anche un profondo innovatore sotto il profilo marziale.
Detto questo, la capoeira viene da Bahia e Bahia è un luogo con una religiosità popolare di origine afro-brasiliana profonda e diffusa oppure collegata a forme di “corruzione” del Cristianesimo.
Vi è poi da dire che il Candomblé e varie forme artistiche come il samba, sono state a lungo proibite in Brasile. Sono state ovviamente praticate, ma in segreto. Quando sono state nuovamente consentite, la loro pratica è stata permessa solo in luoghi chiusi. Quindi, partendo dal fatto che i capoeiristi erano (e sono) persone con una religiosità spiccata legata al Candomblé, nel momento in cui avevano uno spazio a disposizione, ne approfittavano per mettere insieme tutto ciò che non era possibile fare all’esterno. E questo ha favorito ulteriormente la fusione con l’elemento religioso.
Detto questo, le varie epoche della capoeira hanno visto una vera e propria evoluzione e questo lo si comprende bene leggendo i testi delle canzoni. Le canzoni più antiche di capoeira parlano di cose quotidiane assai semplici, come dell’andare al mercato a comprare del pesce. Poi c’è stato un periodo, in particolare sotto la dittatura, in cui la capoeira ha dovuto alleggerire i riferimenti etnico-identitari di origine africana in favore della celebrazione della pratica in sé, intesa come lotta, come arte valorosa.
Le canzoni che sento oggi fanno effettivamente quasi tutte riferimento a divinità o a simboli del Candomblé. O addirittura ne riproducono proprio elementi musicali oppure appartenenti a altre forme religiose, tipo l’Umbanda. La musica della capoeira è molto malleabile e facile alle contaminazioni.
C. Come spieghi questa tendenza?
F. C’è stato un periodo in cui molte canzoni sono state scritte in africano. Sai, il poder negro, il black power brasiliano doveva affermarsi in qualche modo. È probabile che oggi ci sia un ritorno di interesse non tanto per la religione in sé quanto per la cultura che ci sta dietro. E nel momento storico attuale, in cui il governo brasiliano sta perseguitando con decisione certe manifestazioni, credo che il significato politico di certi testi sia forte e preciso.
Tornando alla tua domanda, posso dirti che di sicuro la capoeira è un’arte profondamente spirituale, i praticanti storicamente lo sono molto.
C. Credo che l’interesse per il trascendente appartenga a tutti coloro che praticano discipline che derivano da tradizioni di combattimento. I samurai trovarono grande interesse nello Zen proprio perché dava loro strumenti utili a confrontarsi con il tema della morte, che per loro rappresentava un pericolo reale e costante.
F. O forse è solo che passare sotto a dei calci molto veloci ti porta a sperare in qualche aiuto extra!!!
C. Ah, senz’altro. Ancora grazie Federico.
facebook.com/capoeirapalmaresbologna/
www.capoeirapalmares.it