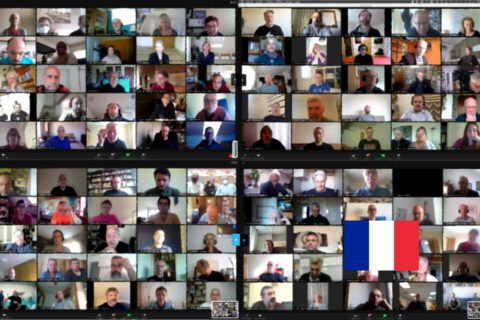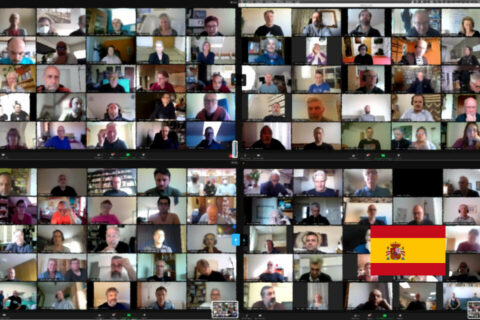Nel suo ultimo articolo, Paolo affronta la spinosa questione dell’organizzazione dei dojo dopo la scomparsa del Doshu e cita come esempio dell’addestramento ad un certo tipo di modello organizzativo i seminari al Furusato. «Molti possono raccontare di come, durante gli stage al Furusato, i praticanti si cimentassero insieme in attività non strettamente correlate all’Aikido, come la costruzione di un forno, la pulizia della struttura, la manutenzione del giardino o delle grondaie.»
Non voglio soffermarmi oltre sul tema dell’organizzazione, ma scrivere su quello dell’identità. O meglio di come identificare in modo corretto ed efficace il tipo di Aikido che faccio. Del resto, è una questione che mi pongo da svariati anni e che ovviamente nelle ultime settimane ho sentito ancora più urgente. Per esprimere il mio pensiero voglio partire proprio dal Furusato.
“Furusato” in giapponese può essere tradotto in svariati modi. “Vecchia casa” innanzitutto e il nostro Furusato effettivamente nuovissimo non è. Ma anche “luogo d’origine” o “città natale”. Esiste persino una canzone tradizionale per bambini che si intitola così e fa riferimento a quest’ultimo significato.

In effetti Sensei dichiarava di aver voluto realizzare un luogo che ricreasse la dimensione fisica dell’Aikido delle origini (il tatami ha dimensioni contenute, l’allenamento viene alternato al lavoro nei campi come a Iwama, ecc.). Ma ancora di più un luogo nel quale vivere in un modo che lui riteneva essere “originariamente” umano ovvero non stravolto dal modello di vita occidentale (e quindi caratterizzato tra le altre cose dall’attenzione al consumo dell’acqua, dall’uso limitato della tecnologia, da una temperatura interna poco “addolcita” rispetto a quella esterna, ecc.).
Un modo di vivere simile a quello delle campagne del Giappone di prima della modernizzazione del Secondo Dopoguerra, che forse lui ricostruiva nei suoi ricordi di bambino (per l’appunto) nato pochi anni dopo la fine del conflitto.
Non voglio raccontare la mia esperienza al Furusato e premetto che più di qualcosa al tempo non mi convinse, ma rimasi colpito dal significato che Sensei aveva dato al luogo e dallo spirito che lo aveva animato nel costruirlo. Più ancora, il Furusato, esprimendo con forza un modo di vivere nel quale il Doshu affermava di credere con fermezza, mi spingeva a chiedermi: «E io come vivo? Come ritengo davvero sia giusto vivere?»
Ritengo che lo stesso ragionamento si possa fare per l’Aikido.
Oggi il nostro Doshu non c’è più. La sua Via nel corso degli anni era divenuta qualcosa di assolutamente personale, lontana sia dall’Aikido, ma anche, seppur in misura minore, dal Ki-Aikido dal quale proveniva. Originale appunto.
La mia natura desidererebbe descrivere la scuola del Maestro Yoshigasaki su una pagina di Wikipedia in maniera analoga, che so, al Progressive Metal: «Il progressive metal è un sottogenere dell’heavy metal sviluppatosi verso la fine degli anni ottanta. Il genere unisce l’aggressività e il volume dell’heavy metal con la maestosità e le ambizioni classiche del rock progressivo.» Poche righe nelle quali riconoscere un’identità artistica collettiva.

Sfortunatamente, credo che nel nostro caso questo non sia possibile. Nel tempo infatti il Maestro Yoshigasaki ha elaborato teorie diverse che si sono alternate o integrate tra di loro, ma trovo sia difficile dare una descrizione sistematica e omogenea del suo pensiero.
Per questo motivo con gli anni ho realizzato che fare lezione cercando di ripercorrere fedelmente il solco teorico o filosofico del Doshu fosse davvero poco efficace dal punto di vista didattico. on so quanti parlino con convinzione, ad esempio, della matematica delle linee o in generale facciano proprio in toto l’approccio di Sensei.
E quanto ha detto durante l’ultimo seminario di Novara testimonia che non è neppure ciò che lui voleva o desiderava per il futuro.
Il Doshu ci ha lasciato un perimetro apparentemente ampio nel quale muoverci, delimitato da due concetti semplici: amore e rispetto. Parole che possono voler dire tutto e niente, ma che possono essere scoperte come principi concreti di pratica e di vita.
Oggi più che mai ritengo che ognuno di noi debba far ritorno al proprio personale Furusato ideale per trovare le ragioni che lo spingono a voler fare un Aikido realmente basato sui principi dell’amore e del rispetto e di conseguenza trovare la propria strada all’interno di quei confini.
A questo scopo sarà utile e importante continuare a osservare i suoi movimenti nei filmati, a leggere e ascoltare le sue parole cercando di cogliere il senso di entrambi. Credo infatti che il Doshu negli anni ci abbia offerto prospettive teoriche diverse proprio per permettere a ognuno di noi di trovare la propria. Come ha detto sempre a Novara: «Io non ho fatto il mio Aikido, ho fatto il vostro.»
Sensei avrebbe voluto dedicare i prossimi dieci anni della sua vita ad aiutarci a sviluppare il nostro Aikido. La malattia glielo ha impedito, dovremo avere la forza di fare il salto da soli.
Il mio Maestro, Beppe, diceva che «non si funziona mai così bene come quando si è sé stessi.» E poi, che «si comprende chi si è e che cosa si vuole veramente solo quando si è da soli.» Almeno a questo fine, ritengo che il periodo di forzata solitudine che stiamo vivendo possa essere utile.
Se ripercorro la mia storia all’inverso e penso a ciò che cercavo quando ho iniziato a praticare mi vengono in mente innanzitutto una maggiore presenza mentale nelle cose che facevo, una migliore consapevolezza del mio corpo e in generale una maggiore solidità personale. Ma soprattutto la possibilità di risolvere i conflitti senza prevaricare o essere prevaricato e di imparare a essere libero dai condizionamenti.
Ecco, vorrei fossero questi i tratti caratterizzanti del mio personale percorso di sviluppo dell’Aikido. E questo quanto vorrei trasmettere agli altri.
I principianti del futuro non saranno conquistati dal brand Aikido, Ki-Aikido di Tohei, Ki-Aikido di Yoshigasaki o chissà cos’altro. Se continueranno a frequentare il dojo dopo le prime lezioni sarà perché rimarranno convinti dall’istruttore, dal suo modo di insegnare e di fare gruppo e dal gruppo degli altri allievi. Del resto, così è sempre stato e così sarà sempre.
Certo, detta così è un “liberi tutti” che non suona benissimo. Essere originali infatti spesso vuol dire essere molto soli. Ma la solitudine da benefica può diventare improduttiva e dannosa: si rischia di appassire o di spegnersi.

Fino al 12 febbraio di quest’anno, l’elemento di condivisione è stato di fatto rappresentato dall’insegnamento e dalle direttive di una persona sola. Oggi la comunità internazionale dei dojo che si riconoscono nell’insegnamento dal Maestro Yoshigasaki dovrà riannodare i propri legami su basi nuove perché i momenti di condivisione e di onesto confronto tra gruppi diversi diventeranno per il singolo un essenziale strumento di crescita personale. E allora la questione dell’organizzazione diventa effettivamente cruciale.
Ma sono certo che saremo in grado di trovare la strada migliore.